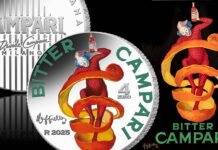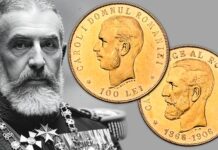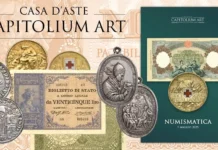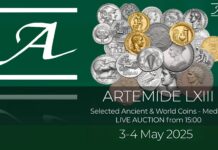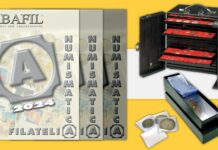Dopo aver retto l’impero bizantino per quasi cinquant’anni, il 15 dicembre 1025 moriva a 67 anni Basilio II; le azioni intraprese con straordinaria energia e ostinazione da questo imperatorene fanno, a parere degli studiosi, il sovrano più capace dell’intera storia bizantina assieme forse al solo Eraclio I. Durante il governo di Basilio II infatti l’impero toccò il suo apogeo politico e militare raggiungendo inoltre una notevole estensione territoriale, spingendosi dal Danubio alla Siria e dall’Italia meridionale al Caucaso.
Anche dal punto di vista della monetazione, il regno di Basilio II offre interessanti spunti di riflessione favoriti sia dalla sua durata del tutto eccezionale, cosa che ha portato a diversi interventi sulle monete nel corso degli anni, sia per la nascita e il consolidamento di alcune innovazioni già presenti in precedenza.
In questo contributo cercheremo di fornire un quadro generale senza pretese di completezza sulla monetazione di questo sovrano, ripercorrendone la vita e le imprese. Lo scopo è infatti quello di ricordare i mille anni dalla morte di questo imperatore attraverso la sua monetazione ed incuriosire coloro che volessero approfondire l’argomento.

Histamenon di Basilio II e Costantino VIII (classe II; 977-989). Oro; mm 26; g 4,40
Basilio II nacque dunque nel 958 dal basileus Romano II (959-963) e Teofano, egli era quindi membro della dinastia macedone che già da tempo sedeva sul trono di Costantinopoli. Vista la prematura morte del padre tuttavia, il giovane Basilio e il fratello Costantino (che aveva due anni meno si lui) per oltre un decennio furono semplici comparse, mentre l’impero era retto da due abili generali, Nicefero II Foca e Giovanni Zimisce, i quali ottennero strepitose vittorie sia ad oriente che ad occidente e, al tempo stesso, scelsero di non eliminare i giovani eredi al trono. D’altra parte, almeno inizialmente, entrambi i principi sembravano molto più interessati ai piaceri piuttosto che al governo.
La situazione iniziò a mutare dopo la morte di Giovanni Zimisce (976) in quanto “fu Basilio, in qualità di primogenito, ad assumersi tutta l’autorità, lasciando al fratello da spartire con lui non più che il titolo di imperatore […] E ci si dovràstupire qui di Costantino, che pur potendo spartire alla pari col fratello il lascito paterno […] gliel’abbia ceduto per la più gran parte”(Michele Psello, Imperatori di Bisanzio (Cronografia), Milano 1984, I, 2). In effetti Costantino VIII non si curò mai degli affari di Stato lasciandoli nelle mani del fratello il quale, come ricorda Psello, gli garantì comunque il titolo imperale.
 Miliaresion di Basilio II e Costantino VIII (classe II; 977-989). Argento; mm 22; g 2,10
Miliaresion di Basilio II e Costantino VIII (classe II; 977-989). Argento; mm 22; g 2,10
Tale situazione è ben evidenziata già nell’iconografia delle prime monete d’oro e d’argento di Basilio II: per quanto riguarda gli histamena, mentre il dritto è dominato dalla figura del Cristo Pantocratore, al rovescio appaiono i due sovrani affiancati (Basilio barbuto a sinistra eCostantino a destra) mentre stringono una croce patriarcale posta tra di loro.
In particolare nella seconda classe si possono notare alcuni dettagli interessanti come l’allargamento del nimbo di Cristo rispetto alle monete degli imperatori precedenti (cosa che permette l’inserimento di decorazioni), la differenza negli abiti dei sovrani (Basilio con un loros “tradizionale” e Costantino con una clamide) e soprattutto una variazione nel modulo della moneta, che passa da 20 a 23 millimetri.
La presenza degli imperatori si ritrova anche nei miliaresia: tralasciando la prima classe, emessa per poche settimane e molto rara, in cui appariva ancora una semplice croce patriarcale posta sui gradini, dalla seconda classe i sovrani vengono rappresentanti al dritto separati da una croce patriarcale posta su un globo poggiato su quattro gradini; anche in questo caso Basilio veste un loros mentre Costantino una clamide ed entrambi indossano una corona con pendilia.

Sigillo da attribuire probabilmente a Basilio il parakoimomenos. Piombo; mm 10; g 29,9
Nonostante l’iconografia delle monete, Basilio II, ormai maggiorenne, nei suoi primi anni di regno non riuscì mai ad esercitare il potere in prima persona: lo Stato infatti era gestito dal potente Basilio il parakoimomenos (gran ciambellano eunuco), il quale governava in sua vece. Tale situazione scatenò presto delle sollevazioni da parte dei militari: volendo seguire l’esempio di Nicefero II Foca e Giovanni Zimisce, il generale Barda Sclero decise infatti di ribellarsi e di tentare il colpo di stato non tanto ai danni della dinastia macedone quanto per deporre e sostituirsi all’eunuco Basilio.
Per bloccare la minaccia, quest’ultimo scelse di richiedere l’aiuto di un altro ambizioso comandante, Barda Foca, il quale in effetti sconfisse il ribelle che si rifugiò a Baghdad dopo diversi anni di guerra. Scampato questo pericolo, Basilio II, ormai ventisettenne, ritenne giunto il momento di liberarsi del suo ingombrante tutore (985) facendolo arrestare e condannandolo all’esilio; successivamente il basileus decise di intervenire personalmente nella zona dell’attuale Macedonia, dove lo zar dei Bulgari, Samuele, aveva iniziato una vasta opera di scorrerie.
Questa prima campagna militare fu un completo fallimento: il sovrano, ancora inesperto, fu sorpreso tra le montagne e cadde in una tremenda imboscata dalla quale riuscì a fuggire in modo vergognoso. Tale disastro spinse immediatamente il generale Barda Foca alla ribellione, alla quale presto si unì Barda Sclero rientrato nei confini imperiali.
Non possiamo soffermarci sulle vicende politico-militari di questa fase, qui sarà sufficiente ricordare solo due aspetti di tale vicenda: per ottenere la vittoria infatti Basilio II fu costretto ad offrire a Vladimiro di Kiev la mano della sorella Anna richiedendo in cambio la conversione del popolo russo al cristianesimo e soprattutto la fornitura di un contingente militare che avrebbe formato la celebre guardia variaga.
Dal punto di visita militare, la battaglia decisiva si svolse presso Abido dove, secondo gli storicidell’epoca, avvenne un fatto incredibile, così ricordato da Psello (Imperatori di Bisanzio, cit., I, 16): mentre Basilio “s’era portato in testa ai suoi e stava a piè fermo con la spada in una mano, nell’altra stringendo l’icona della Madre del Verbo, […] come fu poi che, quando ancora non s’era distanziato molto dai suoi, a un tratto il tiranno [Barda Foca] scivolasse di sella e piombasse al suolo” forse vittima di un improvviso colpo apoplettico o forse avvelenato.
Sta di fatto che, ottenuta la vittoria, Basilio II celebrò la felice conclusione della guerra civile con un particolare miliaresion (classe terza) in cui al dritto i busti dei due sovrani sono sostituiti da quello della Vergine Nicopeia che, vestita con una tunica e il maphorion, tiene davanti a sé un medaglione con all’interno la testa del Cristo infante. Che questa moneta sia da attribuire a Basilio II è testimoniato dal richiamo ai “sovrani” (plurale) e all’aiuto della stessa Vergine (evidente riferimento alla battaglia di Abido) presenti nell’iscrizione.

Miliaresion di Basilio II e Costantino VIII con al dritto la Vergine Nicopeia (classe III; 989). Argento; mm -; g 2,71
L’aver affrontato due rischiose guerre civili e soprattutto la terribile imboscata dei Bulgari costituì un fattore decisivo nella trasformazione del carattere di Basilio II; già Psello(Imperatori di Bisanzio, cit,I, 4) ricordava come costui fosse diventato un “individuo aspro, dal carattere ruvido, facile all’ira e non facile a mutar d’animo, di parco costume, totalmente restio a qualsiasi mollezza” e ancora Ostrogorsky (Storia dell’impero bizantino, Torino 1968, p. 265) ricorda che, una volta ottenuto il pieno controllo dell’impero, Basilio II divenne “cupo e sospettoso, non concedeva a nessuno la propria fiducia, ignorava sia l’amicizia che l’amore. […] Viveva solo, chiuso in sé stesso, e da solo, evitando ogni consiglio, governava l’impero da autocrate nel vero senso della parola”.
E proprio con tale atteggiamento Basilio II gestì lo Stato negli anni successivi: dal punto di vista interno egli ingaggiò una feroce lotta con la potente aristocrazia dei proprietari terrieri (molti dei quali avevano sostenuto le rivolte militari) bloccando le loro acquisizioni di terre e favorendo invece i contadini, i quali costituivano la base dell’esercito imperiale; questa politica fu attuata anche nei confronti della Chiesa, alla quale non fu più concesso di fondare monasteri se non di piccole dimensioni e comunque soggetti ai villaggi.

Histamenon di Basilio II e Costantino VIII (classe IV; 1001-1005). Oro; mm 25; g 4,41
Dal punto di vista militare, negli ultimi anni del secolo Basilio II fu impegnato sia in Bulgaria, dove ottenne importanti vittorie contro lo zar Samuele, sia in Siria contro gli arabi. Proprio contro costoro il sovrano condusse una campagna che si concluse nel 1001 con una pace decennale e con la sistemazione dei rispettivi confini: a parere di Grierson proprio in occasione di questo successo diplomatico (e non a seguito della vittoria nella guerra civile) va datata una nuova classe di histamena (la quarta) la quale presenta alcune innovazioni rispetto alle monete precedenti.
Mentre infatti il dritto mostra sempre il Cristo Pantocratore, al rovescio le corone di Basilio II e Costantino VIII sono decorate da pendilia; la clamide di Costantino poi presenta un tablion (elemento decorativo di forma rettangolare) ed infine si può notare una corona trionfale sospesa al di sopra della testa di Basilio. Questa nuova classe di histamena non sembra essere durata molto a lungo, forse fino al 1005, quando fu sostituita da un nuovo tipo in occasione del ritorno del basileus a Costantinopoli dopo le campagne bulgare.
In quegli stessi anni infatti il sovrano e i suoi generali si impegnarono nella riconquista di tutti quei territori che lo zar Samuele aveva strappato all’impero nel periodo precedente: nonostante il coraggio e la resistenza dei Bulgari, Basilio II si spinse fino al Danubio, infliggendo un colpo durissimo ai propri nemici ma decidendo infine di non proseguire la guerra; secondo alcuni storici infatti l’obiettivo del basileus non era quello di espandere ulteriormente l’impero bizantino ma quello di riprendere i territori perduti e, al massimo, creare degli stati vassalli.
Questo spiegherebbe anche l’assenza di grandi campagne militari nel periodo successivo, che coincide con le ultime classi dei suoi histamena. Tralasciando la rarissima quinta classe (probabilmente un tentativo poco riuscito), la sesta e ultima classe delle monete auree di Basilio II mostra ulteriori piccole modifiche rispetto all’ormai classica iconografia: al dritto il nimbo del Cristo presenta caratteristiche diverse sia negli elementi decorativi che nei bracci della croce del nimbo mentre al rovescio la croce patriarcale che divide i sovrani è sostituita da una molto più semplice. Oltre a questo, le facce di Basilio e Costantino sono più larghe ed infine il diametro della moneta raggiunge i 27 mm, con una triplicecornice circolaresul bordo.
 Histamenon di Basilio II e Costantino VIII (classe VI; 1005-1025). Oro; mm 26; g 4,42
Histamenon di Basilio II e Costantino VIII (classe VI; 1005-1025). Oro; mm 26; g 4,42
La situazione in Bulgaria era tuttavia destinata ad evolversi in modo drammatico: dato che lo zar Samuele aveva ripreso a razziare il territorio, Basilio II decise di muoversi per affrontarlo; nel 1014, nella gola di Cleidon, i bizantini riuscirono a circondare l’armata bulgara infliggendole una pesantissima sconfitta. È a questo punto che si colloca l’evento forse più famoso ma al tempo stesso oscuro del regno di Basilio II: l’ordine delbasileus di far accecare i 14.000 prigionieri bulgari caduti nelle sue mani lasciandone uno orbato di un solo occhio ogni cento, in modo che potesse fare da guida ai compagni; alla vista di questo orrendo spettacolo, lo zar Samuele ebbe un malore e morì.
Non si sa per quale motivo Basilio II avesse deciso di compiere tale efferatezza; secondo alcuni studi recenti è probabile che essa non sia stata realizzata per una gratuita crudeltà ma per vendicare dei soldati imperiali uccisi poco tempo prima. Sta di fatto che, con questa vittoria, il regno bulgaro collassò e, nel giro di pochi anni, il basileus poté incorporarlo nell’impero celebrando questo avvenimento con una grandiosa cerimonia religiosa nel Partenone di Atene, divenuto in quell’epoca una chiesa dedicata alla Vergine.

Trionfo di Basilio II sui Bulgari, miniatura dell’XI secolo (1020 ca.), Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
In quegli stessi anni peraltro si stava compiendo quel processo che avrebbe portato ad una divisione ufficiale tra histamenon e tetarteron; già apparsi al tempo di Niceforo II Foca, i tetartera, monete auree più piccole e spesse dei normali histamena, dal diametro di 17 mm circa, avevano continuano ad essere prodotti in grande quantità anche durante il regno di Basilio II, assumendo caratteristiche specifiche.
Non possiamo soffermarci ad analizzare tali monete nel dettaglio, basti pensare che Grierson ne classifica ben sei tipologie con numerose sottovarianti legate a piccole modifiche nell’iconografia. Qui sarà sufficiente notare alcuni elementi peculiari nella rappresentazione dei sovrani e delle loro insegne: nel primo tipo, ad esempio, entrambi gli imperatori, separati da un labaro, vestono un loros particolarmente elaborato e portano delle corone decorate da una croce mentre nel terzo tipo, in cui il labaro è già stato sostituito dalla croce patriarcale sormontata da un globo, Costantino veste una semplice clamide al contrario del fratello.
È solo con l’ultima classe, datata alla fine del regno di Basilio II, che i tetartera acquisiscono definitivamente una loro indipendenza diventando un tipo di moneta ufficialmente diverso; anche in questo caso l’iconografia dei sovrani mostra delle caratteristiche specifiche, basti pensare al particolarissimo loros indossato da Costantino, con una sorta di scollo a V, e i pendilia delle corone che presentano una forma biforcuta.

Tetarteron di Basilio II e Costantino VIII (classe V; 1000-1005). Oro; mm 24; g 4,41
Sconfitta la Bulgaria, Basilio II non cessò di intervenire ai confini dell’impero: le sue campagne in Georgia e Armenia portarono all’acquisizione di nuovi territori ma soprattutto alla creazione di Stati amici e vassalli ai confini. È probabile tuttavia che, sistemata la situazione nei Balcani e in oriente, il basileus stesse pianificando una grande spedizione in Italia meridionale (dove Bisanzio possedeva ancora dei territori) forse per recuperare la Sicilia, quando si spense improvvisamente a Costantinopoli nel 1025, lasciando l’impero al fratello Costantino VIII e alle figlie di quest’ultimo.
“Aveva statura inferiore alla media, ma la figura era ben proporzionata nei rapporti fra le singole parti e per nulla incurvata. […] Non parlava fluentemente, non levigava le frasi e neppure le estendeva in periodi costrutti, ma le staccava facendo continue pause, più da rustico che da uomo educato; e la sua risata era larga e gli faceva sussultare tutto il corpo”. [Psello, Imperatori di Bisanzio, cit., I, 6)]. Questa e le altre testimonianze degli autori antichi ci presentano un personaggio complesso, la cui personalità, caratterizzata da forti tinte chiaroscurali, è in realtà ben diversa da quella immobile, ieratica e sempre uguale a sé stessa che appare negli histamena e nei tetartera.
 Tetarteron di Basilio II e Costantino VIII (classe VI; 1005-1025). Oro; mm 20; g 4,21
Tetarteron di Basilio II e Costantino VIII (classe VI; 1005-1025). Oro; mm 20; g 4,21
Certamente le fasi oscure del regno di Basilio II il bulgaroctono (sterminatore di Bulgari) sono molte e non possono essere giustificate del tutto dai traumi che subì nei suoi anni giovanili; il suo comportamento dispotico, gli atti crudeli e semplicemente il rifiuto di sposarsi e di avere figli (probabilmente dovuto al timore di cospirazioni da parte degli eventuali parenti) ne fanno un uomo cupo, solo e dal comportamento quasi ossessivo.
D’altra parte egli fu dotato di qualità e tenacia non indifferenti: pur non essendo un generale spregiudicato (a differenza di un NIceforo II Foca o un Giovanni Zimisce) dopo la prima traumatica esperienza egli perseguì la disciplina e la prudenza, non cadendo mai più in imboscate pur combattendo in territori impervi e sconosciuti. Anche dal punto di vista interno, egli riuscì ad accumulare un tesoro immenso pari a duecentomila libbre d’oro e, nel contempo, comprese le esigenze della popolazione, consentendo ad esempio ai Bulgari sconfitti di pagare le imposte in natura e non in denaro.