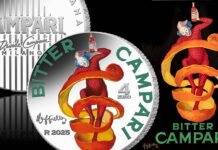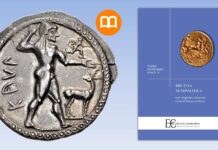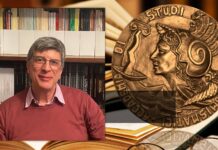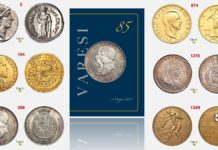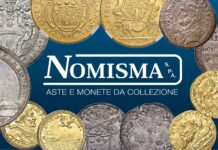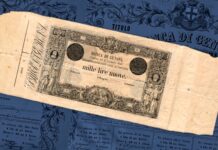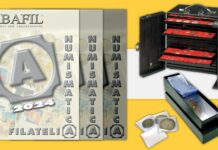Nell’anno ventesimo del suo pontificato (1719-1720), papa Clemente XI Albani fece coniare dalla zecca di Roma, fra le altre monete in oro (g 3,34 per mm 22 circa, Muntoni n. 17) uno “scudo della pace” che al dritto con lo stemma pontificio sormontato da chiavi e tiara abbina un rovescio elegante ed essenziale sul quale troneggia una pianta d’ulivo circondata dalla legenda latina FIAT PAX. “Sia fatta la pace”, dunque, ma quale pace – nello specifico – al di là dell’ovvio valore simbolico della pianticella, simbolo fin dalla Bibbia di avvenuta riconciliazione?

Il rovescio dello scudo della pace coniato nell’anno XX di pontificato di Clemente XI Albani
Mario Traina, ne Il linguaggio delle monete, sottolinea: “L’olivo è un albero di grandissima ricchezza simbolica: pace, fecondità, purificazione, forza, vittoria, ricompensa. In Grecia era consacrato ad Atena e chi lo danneggiava veniva processato. A Roma era consacrato a Giove e a Minerva. Nelle tradizioni ebraica e cristiana l’olivo simboleggia la pace. Alla fine del diluvio la colomba portò a Noè un ramo di olivo; La croce di Cristo, secondo un’antica leggenda, era fatta di olivo e di cedro”.
Ed aggiunge, a proposito dello scudo della pace in questione: “Implorazione di pace per la Guerra di successione spagnola”. Una motivazione puntualmente ripresa anche, ad esempio, da alcuni cataloghi d’asta nei quali la moneta è apparsa nel corso degli anni.

Al dritto della piccola, elegante moneta in oro lo stemma del pontefice urbinate
Il fatto che la lo scudo della pace dell’anno XX si riferisca alla Guerra di successione spagnola, tuttavia, non è affatto scontato, innanzi tutto perché il conflitto, iniziato nel 1701 e che vide contrapporsi da un lato Sacro Romano Impero, Gran Bretagna, Provincie Unite, Ducato di Savoia e Regno di Portogallo e, dall’altro, la Francia con la Corona di Castiglia, l’Elettorato di Baviera e il Ducato di Mantova, era terminato già da alcuni anni, tra il 1713 ed il 1714, a seguito della Pace di Utrecht e del Trattato di Rastadt.
Due atti che avevano modificato gli equilibri tra le potenze europee smembrando parte dell’Impero Spagnolo e ridimensionando, inoltre, la stesa Francia di Luigi XIV a favore dell’Inghilterra e dell’Austria asburgica, la prima divenuta potenza marittima egemone a livello mondiale (insidiata solo dagli Olandesi) e la seconda protagonista assoluta nell’Europa continentale.

La battaglia navale di Capo Passero dell’11 agosto 1718, olio su tela di Richard Paton, 1767: lo scontro fu uno dei più cruenti della Guerra della Quadruplice Alleanza
In realtà, la Pace di Utrecht lasciò aperto più di un problema, il più importante dei quali era il predominio, o anche solo un certo equilibrio di forze, nel bacino del Mediterraneo. Abbastanza da scatenare un’altra guerra, la cosiddetta Guerra della Quadruplice Alleanza, che iniziò nel 1717 su iniziativa spagnola con l’invasione delle isole di Sicilia e Sardegna e terminò, con un’altra grave sconfitta della monarchia iberica, proprio nel 1720. E’ perciò assai più plausibile che Clemente XI abbia voluto imprimere nello scudo della pace dell’anno XX un auspicio per la fine di questo conflitto, e non del precedente.