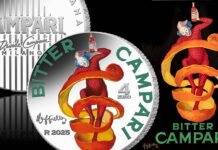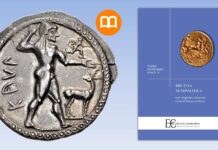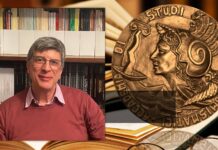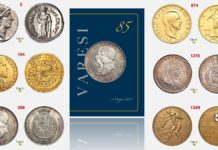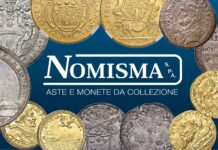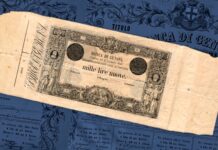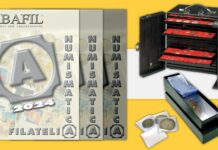La Compagnia di Gesù: mai, nella bimillenaria storia della Chiesa, ordine religioso è stato più ammirato, osteggiato, ricercato, odiato e contrastato. Sino ad arrivare, dopo lo scioglimento di due secoli e mezzo fa, ad un passo dalla completa sparizione. E sino finalmente a riuscire, nel 2013, ad esprimere un pontefice, Francesco.
Quello della Compagnia di Gesù è un cammino tormentato e luminoso allo stesso tempo che attraversa la storia della Chiesa moderna e contemporanea adattandosi ai tempi ed alle missioni, suscitando critiche ed invidie ma, allo stesso tempo, riuscendo – nel caratterizzare la propria opera con un erudito e dotto cattolicesimo militante – ad ottenere i favori dei regnanti e delle élite, diventando un punto di riferimento nella formazione scolastica, accademica, clericale. Un riferimento nella conquista delle anime.

Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556) in un’incisione devozionale del XVIII secolo
Al culmine di una profonda crisi personale Íñigo Lopez de Loyola, nato nel 1491 in un piccolo villaggio nell’entroterra di Donostia (San Sebastian) nella regione di Gipuzkoa nei Paesi Baschi spagnoli, insieme ad alcuni colleghi di studi fonda nel 1534 a Parigi la Compagnia di Gesù. La Societas Iesu è destinata a segnare il cammino della Chiesa romana sino ai nostri giorni.
Il nuovo ordine, fondato su disciplina e completa obbedienza al papa, si vota immediatamente alle missioni: quelle verso il nuovo mondo, le cui rotte iniziano ad inondare l’Europa ma anche lungo le vie, già più battute, dell’Asia, della Cina, dell’India. Il legame indissolubile con i pontefici, per quanto non tutti ovviamente poi entusiasti del potere assunto dalla Compagnia, è testimoniato dal quarto voto che, per i padri gesuiti, oltre a quelli di castità, povertà e obbedienza è il voto specifico di obbedienza al pontefice.

Medaglia in bronzo fusa nel 1626, per la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma: al dritto il cardinale Ludovico Ludovisi (1595-1632) presenta a Dio il modello della chiesa; al rovescio re cascate alludono allo stemma dei Gesuiti
Roma, in particolare la chiesa del Gesù diventa nel 1584 la sede dell’Ordine e nel 1626 inizia la realizzazione anche della bellissima chiesa di Sant’Ignazio, resa celebre dalla fantastica prospettiva della finta cupola di Andrea Pozzo. L’inaugurazione di questo tempio viene immortalata in una medaglia commissionata dal cardinal Ludovico Ludovici sotto Gregorio XV. Realizzata in bronzo e bronzo dorato, al dritto la medaglia presenta sant’Ignazio rivolto a destra: al rovescio una lunga iscrizione.
Il successo della Compagnia di Gesù, che fa della formazione e dello studio i propri più forti caratteri peculiari, è esponenziale ed internazionale così come internazionale era stata la sua costituzione. Papa Paolo III, Farnese, nel 1539 approva l’ordine: cinque anni dopo lo stesso pontefice apre il Concilio di Trento e della Chiesa post-tridentina i gesuiti sono una della colonne. Il fatto è immortalato in un celebre dipinto ripreso anche in una serie di francobolli vaticani stampati nel 1956 nel 4° centenario della scomparsa di Ignazio.

Altra medaglia del 1626 per l’inizio dei lavori della chiesa, in Campo Marzio, dedicata al fondatore della Compagnia di Gesù canonizzato nel 1622 da papa Urbano VIII
Lontano dall’Europa i gesuiti fondano le proprie più discusse fortune: convertendo, adattandosi (celebri sono i riti cinesi di Matteo Ricci ed i riti malabarici in India), attirandosi nel corso dei decenni le accuse dei rigoristi e degli anti curiali, di chi vede nella loro azione l’applicazione troppo morbida del cattolicesimo ma anche, ovviamente, guadagnando gli strali dei nemici di Roma. La strategia dell’accomodamento, dell’ibridizzazione del cattolicesimo con i culti locali, le conversioni “adattate” costano ai chierici in nero l’accusa di lassismo.
Il Settecento è un secolo complicato: per la Chiesa alle prese con le guerre di successione spagnola, austriaca e polacca che vedono ancora una volta gli stati cattolici uno contro l’altro (in particolare Spagna, Francia e Sacro Romano impero), con un decrescente potere pontificio e con “l’eresia illuminista”, ma anche per la stessa Compagnia di Gesù. Sin dai primi decenni del XVIII secolo i seguaci di Ignazio vengono accusati sempre più di rappresentare un oggettivo male del cattolicesimo.

Francobolli vaticani del 1956 che celebrano i quattro secoli dalla morte del fondatore dei Gesuiti
È su questa fase che si focalizza la nostra storia, una storia che da una parte assiste al rinnovo della devozione verso Sant’Ignazio (canonizzato nel 1622 alla riapertura della “fabbrica dei santi” dopo la lunga stasi post luterana) e dall’altra registra la crescente ostilità nei confronti dell’ordine. Il santino colorato a mano dal celebre incisore di Ausburg (Augusta) Johann Martin Will e alcune medaglie portative danno la misura del gusto devozionale del tempo.
Ma, si diceva, sono tempi difficili per l’Ordine. Dopo la metà del secolo nel giro di una ventina di anni la situazione precipita per i chierici soldati di Dio. Il devastante terremoto di Lisbona del 1755 fa da spartiacque. Nel giro di pochi anni la corona portoghese amplia il raggio d’azione nelle colonie sud americane per far ripartire la propria economia, in particolare nel Paraguay, in cerca di terreni, materie prime e schiavi scontrandosi però con le reducciones gesuite.

Un magnifico santino acquerellato a mano di produzione tedesca e una medaglia portativa in bronzo con sant’Ignazio di Loyola e l’angelo custode che guida un fanciullo
Le comunità, laboratori di convivenza e di tecniche di coltivazione, si oppongono alle deportazioni, anche con le armi, e tale atteggiamento è considerato, insieme ad un fallito attentato al re di dubbia matrice, un chiaro segno di insubordinazione proprio da parte degli uomini della Compagnia di Gesù.
La cacciata dei gesuiti dal Portogallo e dalle colonie, firmata da re Giuseppe I, è del 1759. È invece l’attentato a re Luigi XV Borbone del 1757 ad opera di Robert François Damiens, un tipaccio che però aveva avuto nel suo curriculum qualche anno a servizio di una casa di gesuiti, a costare la cacciata dalla Francia, datata 1764.
Neanche la cattolicissima Spagna, madrepatria del fondatore della Compagnia, si esime dal prendere duri provvedimenti contro i soldati di Dio. Insofferente rispetto all’opposizione dei gesuiti alle riforme sociali, Carlo III istruisce un’inchiesta segreta per fare luce sul cosiddetto Motin de Esquilace, una rivolta scoppiata a Madrid nel 1766 che porta alla caduta del potente ministro italiano Leopoldo De Gregorio, marchese di Squillace. L’inchiesta rivela un possibile coinvolgimento dei gesuiti nella rivolta ed il decreto di espulsione arriva nel 1767.

Una delle numerose medaglie di produzione tedesca che, nel 1773 e in seguito, vennero coniate per celebrare la soppressione dei Gesuiti da parte di Clemente XIV Ganganelli
I cattolicissimi sovrani di Portogallo, Francia e Spagna si spingono però anche oltre trovando, dopo la ferma opposizione di Clemente XIII (Carlo della Torre di Rezzonico), in Clemente XIV la sponda ideale per chiudere i conti con la Compagnia di Gesù. Papa Lorenzo Ganganelli, francescano conventuale, col breve Dominus ac redemptor il 21 luglio 1773 sopprime la Compagnia di Gesù cedendo alle pressioni.
I gesuiti si disperdono continuando in quegli anni difficili la propria opera tra la Russia, la Prussia e la Bielorussia. Una efficace medaglia in argento immortala nel metallo quell’epocale passaggio che, di fatto, sembra porre fine ad un’epoca. Opera di Johann Leonhard Oexlein, la medaglia viene coniata in stagno, bronzo, argento e oro con un. Al dritto papa Clemente rivolto a destra, al rovescio Cristo, accompagnato da Pietro e Paolo, caccia i gesuiti che si allontanano guardando Gesù con volto contrito.

Anno 1922: questa grande medaglia di forma ellittica celebra tre secoli dalla canonizzazione di Ignazio di Loyola e dell’altro gesuita Francesco Saverio
In questo modo la Chiesa, alle prese con la tormentata epoca dei Lumi e con la comparsa degli stati nazionali, spera di evitare guai peggiori. A darle una mano, in verità, è quanto accade di lì a pochi anni. La Rivoluzione francese che tra il 1789 ed il 1799 demolisce l’Ancien regime spargendo democrazia e terrore in Francia ed il successivo regime napoleonico portano ad una reazione che, diventata concreta dopo il 1815, trova proprio nella Chiesa il baluardo dell’Europa dei monarchi.
Quando nel maggio 1814, di rientro dalla prigionia di Fontainbleu, papa Pio VII torna in una Roma festante, uno dei primissimi documenti a cui mette mano è la bolla Sollicitudo omnium ecclesiarum che sancisce nel luglio dello stesso anno la ricostituzione della Compagnia di Gesù la cui attività “in esilio” in Bielorussia, Inghilterra, Napoli e Sicilia aveva comunque avuto l’avallo pontificio sin dalla fine del ‘700.
Da allora la Compagnia di Gesù ha riacquistato il suo ruolo in difesa della Santa Sede non senza però, nel corso di questi ultimi due secoli, continuare ad attirare a sé nemici e critici. L’elezione di papa Francesco, al secolo Jorge Bergoglio, il 13 marzo 2013 ha fissato un nuovo tassello nel tracciato della storia.